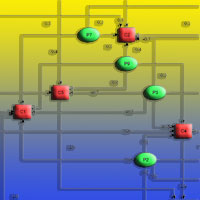The sound bases of systemic silviculture
Forest@ - Journal of Silviculture and Forest Ecology, Volume 6, Pages 337-346 (2009)
doi: https://doi.org/10.3832/efor0603-0006
Published: Nov 23, 2009 - Copyright © 2009 SISEF
Commentaries & Perspectives
Abstract
Following recent critiques on systemic silviculture, the author examines the principles, scientific consequences and practical implications of this theory. Systemic silviculture is based on the assumption that the forest is a complex biological system. This means abandoning the reductive, mechanistic and deterministic paradigm that has characterized forest science until the last century. If the forest is a complex biological system then its properties cannot be reduced to those of its components. According to this assumption, the author analyzes the concepts of forest structure, predictability and unpredictability of forest ecosystem processes, intrinsic value and rights of the forest. Systemic silviculture is characterized by an adaptive approach which has the flexibility and the capacity to respond to environmental retroactions which are fundamental for the governance of complex and adaptive systems. The author concludes that the bases of systemic silviculture are unassailable and surely much sounder than those of “naturalistic” silviculture, or at least of that type of silviculture which, trying to define “natural structural models” for forest ecosystems, is still anchored to the old, classic, paradigm of natural resource management and conservation.
Keywords
Classic paradigm, Complex biological systems, Adaptive approach, Forest management
Premessa
Nel 1996 è stata proposta la selvicoltura sistemica, diversa nei presupposti, negli obiettivi e nelle ricadute operative rispetto alla selvicoltura classica ([15],[16]). Su questa proposizione, a seguito del terzo Congresso di selvicoltura svoltosi a Taormina dal 16 al 19 ottobre del 2008, si è riaperto un ampio dibattito. Sulla stampa tecnica e scientifica sono stati pubblicati numerosi scritti, per lo più su posizione critiche, e nella comunità on-line è in corso un vivace scambio di idee (ForumForeste: ⇒ http://www.forumforeste.it).
Credo sia utile ritornare sui presupposti che hanno portato alla enunciazione di questa teoria, alle conseguenze scientifiche e alle implicazioni applicative che ne derivano. Il mio obiettivo è dimostrare come questi diversi e interconnessi aspetti formino un sistema concettuale e operativo che risponde ai requisiti di coerenza, trasparenza e applicabilità e che si colloca in una prospettiva di radicale cambiamento rispetto all’approccio che ha caratterizzato un periodo ormai concluso, non solo nelle Scienze forestali ma anche nel più vasto campo della gestione e della conservazione delle risorse naturali.
La selvicoltura sistemica: dall’idea alla teoria
La teoria della selvicoltura sistemica nasce dalla presa d’atto che il bosco è un sistema biologico complesso ([9], [14], [15]). Sul piano epistemologico questa constatazione comporta il superamento del paradigma riduzionistico, meccanicistico e deterministico che ha caratterizzato le Scienze forestali fino al secolo scorso ([17]).
Sul piano etico la teoria della selvicoltura sistemica riconosce al bosco, in quanto sistema biologico complesso, valore intrinseco e quindi lo status di soggetto di diritti.
Sul piano operativo la selvicoltura sistemica si fonda sui seguenti principi:
- interventi cauti, continui e capillari, basati su un criterio colturale, svincolato da qualsiasi riferimento al concetto di normalizzazione del bosco, con l’obiettivo di sostenere i processi naturali di autorganizzazione del sistema;
- mantenimento di un livello provvigionale minimo, a garanzia della funzionalità del sistema;
- continua verifica delle risposte del sistema in modo da adattare via via gli interventi secondo l’approccio scientifico per prova ed eliminazione degli errori.
Sul piano della gestione la selvicoltura sistemica prevede l’adozione di schemi aperti, flessibili, adattativi.
Il superamento del paradigma classico
Fino a gran parte del secolo scorso nella utilizzazione delle risorse naturali si è fatto riferimento a quello che in ecologia è stato definito il “paradigma classico” ([38]). Questo paradigma, secondo Hilborn et al. ([25]), ha trattato le dinamiche delle popolazioni e degli ecosistemi come se si svolgessero in un ambiente immutabile e secondo andamenti prevedibili. L’interesse scientifico è stato rivolto all’individuazione delle “leggi” che regolano i rapporti fra nascite, morti e accrescimento somatico. Sulla base di questo paradigma, finché il tasso di utilizzazione non eccede il tasso di rinnovazione, la risorsa non si esaurisce. Pertanto, secondo tale visione, la continuità della produzione dipenderebbe dalla prevedibilità del tasso di rinnovazione.
Un esempio di questo modo di interpretare la realtàè stato recentemente fornito da Anfodillo ([1]) quando sostiene: “È noto, anche, che per garantire la sopravvivenza di una popolazione ci debba essere [una] certa struttura cronologica ed uno specifico rapporto tra i sessi. Così come per le popolazioni animali una certa struttura cronologica è necessaria, così per la foresta, si potrebbe ipotizzare che una certa struttura debba essere presente per garantirne la sopravvivenza. Dato che per la foresta conta più la dimensione che l’età, ogni foresta dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di un determinato numero di individui in ogni classe dimensionale.”
Coerentemente con questo paradigma, la selvicoltura e l’assestamento forestale hanno considerato il bosco come un insieme di alberi che può essere organizzato in modo da rispondere alle esigenze della gestione. Queste discipline hanno perseguito da un lato la perpetuità del bosco attraverso tecniche colturali atte a garantire la rinnovazione del popolamento arboreo - il trattamento - e dall’altro la pianificazione delle operazioni selvicolturali nel tempo e nello spazio nel tentativo di ottenere un prodotto annuo massimo e costante o, più recentemente, la durevolezza dell’erogazione di beni e servizi ([24]). Di conseguenza, il bosco viene sempre e comunque concepito come una entità strumentale.
Sulla base di tali principi è stato costruito un protocollo di analisi e procedure che trova il fondamento nei meccanismi biologici della rinnovazione delle specie arboree e nelle “leggi” che regolano l’accrescimento dei soprassuoli forestali. Questo approccio si basa su due assunti: a) il presupposto della continuità della produzione e b) la nozione di prevedibilità, ovvero la possibilità di prevedere e di predeterminare gli stati e i processi che caratterizzano il bosco.
Tale paradigma ormai è chiaramente messo in discussione. Negli ultimi decenni del secolo scorso sono state formulate ipotesi sul funzionamento degli ecosistemi e sulla peculiarità dei sistemi complessi, caratterizzati da continue e imprevedibili modificazioni e fluttuazioni ([26], [45], [36], [25], [27], [44], [20]).
In campo forestale questo cambiamento non è stato ancora pienamente percepito, nonostante che intorno alla necessità di cambiare il paradigma di riferimento nella gestione forestale da tempo si sia avviato, e non solo in Italia, un vasto dibattito. Mladenoff e Pastor già nel 1993 ([40]) osservavano che la selvicoltura classica (classic silviculture) appartiene a un paradigma fondato su una prospettiva di breve periodo, che interpreta la foresta come immobile in uno stato costante e con una produzione relativamente costante. Essi concludevano che occorre cambiare, passare dal gestire gli stati al gestire i processi, dal concentrarsi sugli alberi al concentrarsi sugli ecosistemi. Secondo Behan ([3]): “l’approccio ai problemi forestali che ha caratterizzato il XX secolo differisce poco da quello del XVIII e del XIX secolo.”
Il riconoscimento del bosco come sistema biologico complesso è coerente con quanto ormai da vari decenni si va discutendo in ecologia. Ha rappresentato la base per un salto paradigmatico nelle Scienze forestali e, all’inizio del terzo millennio, costituisce il punto di partenza per qualsiasi discorso innovativo sulla selvicoltura e sulla gestione forestale.
Questo è tanto più vero perché, come ha scritto Popper ([49]): “Abbiamo molte ragioni per credere che il mondo sia unico: una combinazione unica e altamente complessa - forse perfino infinitamente complessa - di occorrenze di processi interagenti.”
Bosco strutturato e astrutturato
Il fatto che un bosco sia caratterizzato dalla presenza di alberi, organismi vegetali generalmente longevi e individualmente ancorati a un determinato posto, ha portato a considerare la struttura di un bosco, cioè la distribuzione nello spazio dei diversi elementi, caratterizzati dall’età e/o dalle dimensioni, come qualcosa che può essere individuato e descritto in maniera univoca. Nell’ambito del “paradigma classico” la selvicoltura ha quindi concentrato l’attenzione sperimentale e applicativa sull’individuazione di “strutture” ritenute ottimali in funzione della/e specie, della stazione e degli obiettivi della coltivazione. Così sono stati definiti il modello strutturale dei boschi coetanei e quello dei boschi disetanei e messe a punto forme di trattamento per conseguire e mantenere nel tempo l’uno o l’altro modello. L’obiettivo, più o meno immediato, è quello di ricondurre la struttura verso un modello considerato “regolare”.
Piussi ([46]), in merito ai sistemi selvicolturali, afferma: “Una delle principali conseguenze della manipolazione della foresta è la trasformazione della struttura spaziale del bosco, in modo da organizzare le chiome degli alberi secondo modelli funzionali all’economia umana. L’uomo realizza attraverso la coltivazione, determinati tipi strutturali, soddisfacenti sotto il profilo della gestione economica [...]”.
Recentemente La Marca ([35]) ha sostenuto che non si deve confondere “l’irregolarità strutturale con la complessità bio-ecologica, che è cosa profondamente diversa”. Forse egli ritiene che la “regolarità” sia una caratteristica della naturalità: una proposizione assolutamente inaccettabile sul piano scientifico.
Riconoscere che il bosco è un sistema biologico complesso vuol dire comprendere che le sue proprietà non sono riducibili direttamente a quelle dei suoi componenti. Le caratteristiche di ogni bosco, in ogni momento, sono il frutto delle complesse interazioni che si sono svolte, e continuano a svolgersi, come reazione a eventi naturali o ad azioni umane. Le relazioni interne si connettono con una rete esterna di relazioni più ampia, in un processo sempre in atto e che, appunto per questo, comporta il principio di incertezza, di indeterminatezza e di incompletezza, tipico di tutto ciò che è complesso.
Coerentemente con questa concezione, la selvicoltura sistemica non fa riferimento a una determinata struttura. Il bosco è astrutturato perché non può essere strutturato a priori. La struttura è una proprietà emergente del bosco, ovvero una conseguenza delle interrelazioni fra interventi e reazione del sistema, intrinsecamente imprevedibile e continuamente mutevole nel tempo e nello spazio e, pertanto, non codificabile.
Questa proposizione è stata recentemente messa in discussione da Anfodillo ([1]) quando sostiene che, in termini ecologici, non può esistere un bosco astrutturato. Alla luce di quanto sopra e al contrario di quanto pensa Anfodillo, la domanda da porsi è piuttosto se, in termini ecologici, possa invece esistere un bosco strutturato.
Ovviamente la risposta è no. A meno di non proseguire sulla strada di una selvicoltura che, più o meno consapevolmente, tende alla normalizzazione e alla regolarizzazione del bosco secondo modelli predefiniti, e quindi secondo un approccio che è quanto di più lontano ci possa essere dall’agire in armonia con la natura.
A tal proposito suggerisco di leggere Kimmins et al. ([34]) su complessità e modelli predittivi in selvicoltura. Dopo aver riconosciuto la “complessità” degli ecosistemi forestali, gli Autori verificano uno di questi modelli applicandolo: 1) a piantagioni di douglasia sottoposte a diverse combinazioni di fertilizzazione e diradamento; e 2) a piantagioni di abete cinese (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook) coltivate con turni di 20 anni. Mi pare chiaro che essi hanno lasciato il campo della selvicoltura per entrare in quello dell’arboricoltura da legno.
Inoltre, secondo Anfodillo, “il vicolo cieco imboccato dalla selvicoltura sistemica risulta evidente: negando la possibilità da parte del gestore di immaginare e seguire specifici modelli strutturali non resta che la possibilità di lasciarlo completamente libero senza alcuna indicazione tecnica se non quella di valutare il risultato a posteriori (con significativa probabilità di compiere errori).”
Sul rischio di compiere errori tornerò più avanti. Qui vorrei far riflettere sull’uso del termine immaginare in questo contesto. Forse Anfodillo non si è reso conto del suo significato. Come ha scritto Machiavelli: “E molti si sono immaginati repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero”.
Prevedibilità e imprevedibilità
Anfodillo ([1]) conclude che la selvicoltura sistemica sembra alzare bandiera bianca di fronte alla possibilità dell’uomo di comprendere il funzionamento della foresta, che diviene, quindi, realtà“inattesa ed imprevedibile”. Citando Popper ([48]) a proposito della fertilità della credenza metafisica nella causalità rispetto alla metafisica indeterministica, egli si dimostra preoccupato che la selvicoltura sistemica possa “emettere proibizioni” per limitare la libertà della ricerca.
Forse è utile ricordare quanto afferma Popper ([49]): il fatto che ogni evento ha una causa non è sufficiente per argomentare a favore del determinismo. Tra l’altro, il requisito fondamentale per poter formulare qualsiasi ipotesi predittiva secondo il determinismo scientifico, ovvero la conoscenza delle condizioni iniziali con un sufficiente grado di precisione, non è e non può essere soddisfatto quando si tratta di sistemi complessi.
Certo, è davvero “intrigante” come concludono West et al. ([54]), in uno dei lavori citati da Anfodillo ([1]) come esempio di fertilità nella ricerca della causalità, “che la foresta possa essere vista astrattamente come una distribuzione approssimativamente uniforme di ’tubi vascolari’ di uguale lunghezza ciascuno dei quali trasporta la stessa quantità di energia e risorse”. E ancora: “la struttura matematica e le caratteristiche fisiche della rete ’virtuale’ di alberi interconnessi nella foresta sono essenzialmente identici alla rete di rami nel singolo albero”.
La domanda è se questa raffigurazione della foresta possa essere di qualche utilità per guidare l’attività del selvicoltore. Ovviamente la riposta è no. A meno di non arroccarsi su una selvicoltura che ho già avuto occasione di definire, questa sì, virtuale.
I risultati di queste ricerche forse possono essere utili per tentare di comprendere alcuni parziali e limitati aspetti del funzionamento degli alberi di una foresta, ma non certo per definire improbabili modelli di naturalità o di funzionamento “naturale” sui quali plasmare la struttura del bosco. Solo la verifica a posteriori delle reazioni di un determinato bosco all’intervento potrà realmente quantificarne gli effetti, seppure su un numero di parametri sempre e comunque infinitamente piccolo rispetto all’infinitamente grande delle interazioni tra i molteplici componenti del sistema. E, comunque, i risultati della ricerca non sono mai generalizzabili. Sta qui la differenza sul piano puramente scientifico, cioè l’impossibilità di oggettivare i risultati, e mi pare non sia cosa di poco conto.
Vorrei ricordare quanto ha scritto Ciancio nel 1998 ([10]): “Per chi è abituato a procedere secondo schemi basati sulla cultura analitica di causa-effetto, imbattersi nei processi soggiacenti a un sistema è un impatto rilevante e presenta difficoltà non facilmente superabili”.
Al contrario di quanto sostiene Anfodillo, ritengo molto più preoccupante proporre di usare in modo predittivo in selvicoltura modelli che sono inevitabilmente semplificati a fronte della complessità dei processi e delle interazioni che avvengono non solo negli ecosistemi forestali ma anche nelle loro interrelazioni con i sistemi sociali ed economici.
Come afferma Dyson ([19]): “Quando faccio previsioni, non sto parlando come uno scienziato. Sto parlando come un raccontafavole, e le mie previsioni sono fantascienza piuttosto che scienza”.
Valore intrinseco e i diritti del bosco
L’attribuzione di diritti al bosco è una delle proposizioni che ha suscitato le maggiori reazioni critiche nei confronti della selvicoltura sistemica.
A questo proposito vorrei far riflettere su alcuni aspetti. Attribuire al bosco lo status di soggetto di diritti significa riconoscere al bosco valore intrinseco e non più solo valore strumentale ([13]). Al contrario del valore strumentale, il valore intrinseco è il valore che qualcosa ha indipendentemente dal soddisfacimento delle esigenze umane.
L’idea di attribuire valore intrinseco a entità naturali non-umane e alla natura nel suo insieme è stato oggetto di grande controversia fra i filosofi che si occupano dei rapporti fra uomo e natura.
Il dibattito si è incentrato sulla individuazione di chi e che cosa può avere valore intrinseco e se esso esiste oggettivamente o deve essere attribuito soggettivamente ([8]). Nel tempo valore intrinseco è stato attribuito ad animali coscienti ([50]), animali senzienti ([53]), a tutti gli esseri viventi ([52]), alle specie ([6], [51], [30]); alle comunità biotiche ([7]); agli ecosistemi ([51], [30]), ai processi evolutivi ([51]).
Quando le istituzioni prendono atto con documenti ufficiali dei cambiamenti etici che avvengono nella società, vuol dire che il nuovo ormai non è più tale, ma è divenuto parte del comune sentire. Solo un paio di esempi: il Millennium Ecosystem Assessment ([39]) dichiara esplicitamente che la biodiversità e gli ecosistemi hanno anche valore intrinseco; il 19 settembre 2006, prima di una lunga serie, la cittadina di Tamaqua, nella contea di Schuykill in Pennsylvania, ha approvato una ordinanza rivoluzionaria che ha cambiato radicalmente il concetto di soggetto di diritti giuridici. In pratica, questa ordinanza riconosce alle comunità naturali e agli ecosistemi lo status di persona giuridica con propri diritti ([5]).
Ma, al di là di altre considerazioni, vi è un aspetto che riguarda la questione dei diritti alle entità e comunità non umane che ha una rilevante importanza e che ritengo venga spesso ignorato. Se al bosco si riconosce solo valore strumentale, allora è concesso utilizzarlo a fini commerciali. In questa prospettiva tocca a chi ritiene che si debbano porre limiti allo sfruttamento dimostrare perché questo è necessario. Se, al contrario, al bosco è attribuito valore intrinseco, allora tocca a chi vuole utilizzarlo dimostrare che ciò non lo danneggia irreparabilmente o mette a rischio la sua stessa essenza e funzionalità. Questo vuol dire spostare l’onere della prova. Come sostiene Fox ([22]) riconoscere al mondo non-umano valore intrinseco ha un effetto drammatico sul quadro di riferimento del dibattito ambientale e sulle politiche decisionali.
Alcuni hanno contestato l’attribuzione di diritti al bosco affermando che l’uomo ha bisogno del bosco, mentre il bosco non ha bisogno dell’uomo. Forse non hanno compreso che riconoscere i diritti del bosco non vuol dire togliere il diritto all’uomo, in quanto parte integrante del sistema, di intervenire nel bosco. Vuol dire, invece, cambiare il modo di intervenire: passare da una selvicoltura che impone al bosco la struttura che si ritiene più utile per le esigenze umane a un approccio che rispetta l’autorganizzazione del bosco.
Dalla teoria alla pratica: selvicoltura reale e selvicoltura virtuale
La selvicoltura sistemica è stata accusata di rappresentare un costrutto teorico, cioè di non essere aderente alla realtà. Peraltro secondo Piussi ([47]) essa è tuttora priva di una verifica empirica.
Partendo da considerazioni opposte rispetto a queste affermazioni, ho recentemente definito “virtuale” la selvicoltura descritta nei testi e prescritta nei piani di assestamento. Questa affermazione ha sollevato alcune perplessità e reazioni contrarie.
La traduzione applicativa della selvicoltura sistemica è uno degli aspetti che ha stimolato la maggior parte degli interventi sull’originalità di questa teoria rispetto alla selvicoltura naturalistica, interventi che hanno evidenziato anche contraddizioni e una certa confusione terminologica oltre che concettuale.
Secondo Anfodillo ([1]) la sostanziale differenza della selvicoltura sistemica rispetto alla selvicoltura naturalistica sta nel fatto che in quest’ultima “determinati modelli strutturali naturali hanno sempre rappresentato la base di riferimento per la definizione degli interventi selvicolturali, come ci ha insegnato a Padova Lucio Susmel”. E che questo sia un elemento discriminante non vi è alcun dubbio.
Secondo Wolynski ([55]), viceversa, la selvicoltura sistemica non differisce dalla selvicoltura naturalistica. Secondo questo Autore “la teoria del bosco disetaneo, ma sopratutto i suoi esempi di applicazione [...] hanno avuto e mantengono un posto di rilievo nella definizione della selvicoltura prossima alla natura. Ma non si può dimenticare anche il ruolo avuto dagli esempi di gestione dei cedui composti francesi nella definizione dei principi della selvicoltura d’albero [sic!] che così fortemente si collegano ad una selvicoltura nella quale la cura del bosco coincide con il momento dell’utilizzazione”. Proprio in questo si dimostra come la selvicoltura naturalistica differisca profondamente dalla selvicoltura sistemica.
Wolynski prosegue sostenendo una posizione opposta a quella di Anfodillo e cioè che “la struttura non è l’obiettivo della gestione, ma piuttosto la conseguenza” di un approccio in cui gli interventi selvicolturali devono “derivare da una osservazione attenta del popolamento, agganciandosi e adattandosi alle esigenze puntuali della natura e alla sua dinamica piuttosto che alle caratteristiche di una curva.”
Anche secondo Paci ([43]) non esiste una sostanziale differenza fra quanto propone la selvicoltura sistemica e altri “modelli selvicolturali” che l’hanno preceduta. Egli sostiene che “le forme flessibili di trattamento” che a suo parere sono caratteristiche della selvicoltura sistemica, richiamano direttamente “i tagli successivi su piccole superfici (caratterizzati dal fatto che tempi e modi degli interventi non sono fissati a priori ma variano secondo aspetti strutturali ed economici)”.
Evidentemente Paci non ha pienamente compreso i principi che stanno alla base della teoria della selvicoltura sistemica che non fa, né può fare, riferimento ai tagli successivi, siano essi uniformi o su piccole superfici, perché questi rispondono sempre e comunque alla logica di regolarizzare il bosco in funzione di obiettivi, appunto, economici.
A ben vedere, poi, secondo Paci ([42]) la selvicoltura naturalistica include qualsiasi tipo di trattamento: non esclude a priori nemmeno “i tagli rasi che” - egli afferma - “pure non garantiscono uno dei principali requisiti tradizionali della selvicoltura su basi naturali, cioè la continuità della copertura arborea del suolo”. Tra l’altro, qui c’è da chiedersi se l’Autore consideri la selvicoltura naturalistica e la selvicoltura su basi naturali due cose diverse oppure no.
Su cosa si debba intendere per “selvicoltura naturalistica” rimando a quanto ha recentemente scritto in maniera molto chiara Iovino ([28]). Sulle altre definizioni ritengo che spetta a chi le propone cercare di chiarirne il significato e gli eventuali elementi distintivi rispetto alla selvicoltura naturalistica.
Piussi ([47]) auspica che in tutti i boschi vengano sistematicamente adottati i principi della selvicoltura naturalistica. Più avanti afferma che la selvicoltura naturalistica in Trentino è mutuata da esperienze altrui. Trovo molto preoccupante pensare di generalizzare esperienze sviluppate in altri contesti ambientali e sociali piuttosto che avvalersi di un approccio - quello proposto dalla selvicoltura sistemica - che fonda i criteri di intervento su una attenta lettura di ciascun bosco, non solo in relazione alla propria organizzazione interna, ma anche in rapporto ai saperi locali e alle interazioni con i relativi sistemi socio-economici. La selvicoltura sistemica, proprio perché non propone ricette univoche, o peggio ancora, importate da altre realtà, consente di cogliere l’essenza di ciascun bosco in ogni parte d’Italia.
A ben guardare in molte zone del nostro Paese esiste una selvicoltura reale che si è evoluta al di fuori degli schemi della selvicoltura classica e di strumenti codificati di gestione, anzi quasi sempre in contrasto con questi.
In ambiente appenninico la gestione delle fustaie presenta alcune evidenti differenze tra le proprietà pubbliche e private. Nelle prime, solo in parte dotate di piani di assestamento, peraltro pochissimi dei quali applicati, la gestione è stata incentrata sugli schemi classici della selvicoltura. Partendo da una accurata disamina dei piani di assestamento di alcuni complessi forestali di rilevante interesse dell’Appennino, Iovino et al. ([29]) mettono in evidenza come gli indirizzi selvicolturali facciano ovunque riferimento ai boschi coetanei.
Il trattamento prescritto dai piani è sempre stato, salvo rarissime eccezioni, il taglio raso con reimpianto per le abetine, i tagli successivi uniformi per le faggete e le cerrete, il taglio raso a strisce per le pinete di laricio.
Nelle fustaie delle proprietà private invece esistono significativi esempi di forme peculiari di coltivazione del bosco, basate sull’attenta osservazione della realtà naturale locale e sulla necessità di differenziare la produzione. Mi riferisco a quelle forme di trattamento recentemente descritte che fanno parte dei saperi locali, tramandate da padre a figlio attraverso una esperienza plurisecolare e che hanno garantito il mantenimento dell’efficienza produttiva e funzionale del bosco ([12], [11], [37], [2]).
Dalla selvicoltura alla gestione
Sul piano della gestione, l’applicazione della selvicoltura sistemica comporta obiettivi chiari e necessariamente un cambiamento di metodo nell’assestamento ([41]). L’approccio adattativo diviene fondamentale: si procede attraverso l’attento e continuo monitoraggio delle reazioni del bosco agli interventi. La gestione procede secondo un continuum coevolutivo fra intervento umano e reazioni del sistema, che di fatto esclude il finalismo tipico dei processi lineari che portano alla normalizzazione del bosco ([13], [14]).
Nel mondo forestale “la normalizzazione” del bosco molto spesso è ancora vista come l’obiettivo finale di qualsiasi attività di gestione e pianificazione, anche quando la produzione non è più il fine primario: un imprinting difficile da superare. Così La Marca ([35]) prefigura un concetto di normalità“oltremodo più ampio di quello cui si è fatto riferimento in passato” che dovrebbe garantire anche il raggiungimento di un “assetto vegetazionale più vicino alle condizioni naturali in cui si opera”. Forse l’Autore non ha chiaro il concetto di bosco normale, oppure è rimasto ancorato a una visione della natura ormai scientificamente superata.
L’approccio gestionale della selvicoltura sistemica fa propria la flessibilità e la capacità di rispondere alle retroazioni ambientali richieste per la governance di sistemi complessi e adattativi ([21]). La selvicoltura sistemica riconosce che gestire un bosco significa - per usare una efficace metafora di [31] a proposito della gestione degli ecosistemi - trovare la strada attraverso un territorio parzialmente sconosciuto piuttosto che tracciare un percorso scientificamente determinato verso un punto di arrivo noto.
Questo modo di operare recupera l’essenza di due metodi che sono stati considerati al margine o addirittura fuori dall’assestamento, e cioè il criterio colturale, liberato da qualsiasi riferimento alla normalità del bosco, e l’approccio adattativo che era già insito nel metodo del controllo di Gurnaud, seppure ancora legato alla visione produttiva del bosco ([13], [41]).
Il concetto innovativo di provvigione minimale, cioè il livello minimo di provvigione da rilasciare sempre e comunque nel bosco, insieme all’indicazione di procedere con interventi cauti, continui e capillari, rispondono all’esigenza di applicare il principio di precauzione.
Il monitoraggio degli effetti della reazione dei popolamenti agli interventi effettuati è la guida per apportare eventuale correttivi, adottando l’approccio per tentativi ed eliminazione degli errori. La reazione a ogni intervento dovrà essere monitorata utilizzando indicatori opportunamente scelti, non come soglie di riferimento, ma come parametri per misurare il cambiamento relativo nel tempo ([18]).
Nonostante si dichiari ignorante degli aspetti applicativi, Anfodillo ([1]), nella sua critica alla selvicoltura sistemica, si sbilancia nell’esprimere un parere in merito alle conseguenze della sua applicazione che egli trova “preoccupanti per i selvicoltori oltre che per gli ecologi” giustificando tale preoccupazione con il fatto che la selvicoltura sistemica propone, appunto, il procedimento per tentativi ed eliminazione degli errori.
Anfodillo, citando Kimmins ([32]), sostiene che l’approccio per prova ed errore “ha fornito, in passato, anche indicazioni importanti ma che, ora, sta diventando via via sempre meno utile”. Ancora recentemente Kimmins ([33]) è tornato sulla questione affermando testualmente: “Il sapere tradizionale che è stato accumulato attraverso [l’approccio] per prova ed errore per oltre centinaia e a volte migliaia di anni, fino a ora è stato in larga misura trascurato da molti scienziati occidentali. Questo sapere tradizionale si è dimostrato efficace nelle condizioni sociali, gestionali e ambientali passate ma […] potrebbe non essere altrettanto efficace in condizioni diverse.”
È evidente che Kimmins, e di conseguenza Anfodillo, non colgono la caratteristica saliente dell’approccio per tentativi ed eliminazione degli errori che, come hanno chiaramente evidenziato Berkes et al. ([4]), è insito nei processi di costruzione dei saperi tradizionali, e cioè la capacità di adattarsi continuamente al cambiamento della risorsa e del contesto.
Inoltre, se un tale approccio ha dato risultati soddisfacenti per centinaia, a volte migliaia di anni, come afferma Kimmins, è prova evidente che è stato in grado di affrontare già in passato cambiamenti ambientali, sociali ed economici. Il fatto, che sfugge a Kimmins e ad Anfodillo, è che con questo tipo di approccio quello che conta non è il punto di arrivo ma come si percorre la strada, adattandosi continuamente al cambiamento che è una realtà imprescindibile quando si tratta di complessi sistemi ecologici e sociali ([4]).
Ugualmente in difficoltà nel comprendere questo concetto si dimostra anche La Marca ([35]) quando, pur senza citare direttamente la selvicoltura sistemica, scrive: “Se le prescrizioni assestamentali non sono chiare, o peggio ancora lasciano mano libera a chi è incaricato dell’applicazione del piano con l’assunto, che potrebbe essere anche pretestuoso, che ogni intervento è la conseguenza di quello precedente e condiziona quello successivo, è possibile una generale disattenzione degli obiettivi specifici che hanno dato origine all’assestamento forestale”. Egli, evidentemente, oltre a non aver letto o a non aver esaminato con attenzione quanto propone la selvicoltura sistemica, rimane saldamente ancorato a una visione che fa riferimento a procedure di tipo “comando e controllo” che si sono dimostrate assolutamente inadeguate per la gestione e la conservazione delle risorse naturali ([27]).
Le forme di trattamento tradizionale sviluppate in varie parti d’Italia e prima citate, si basano proprio sull’approccio per prova ed errore. Per esempio, in pinete di laricio della Sila, i proprietari, sulla base di una esperienza pluricentenaria, hanno messo a punto una forma di gestione del bosco che mantiene una pineta efficiente attraverso la pronta e vigorosa affermazione della rinnovazione naturale e dall’altro non utilizza mai più dell’incremento del bosco. L’equilibrio tra utilizzazione e incremento è mantenuto dal proprietario non sulla base di modelli strutturali o auxometrici predeterminati, ma sulla base di un processo intuitivo che procede adattando costantemente l’intervento alla risposta del bosco ([12]).
Conclusioni, ovvero le solide fondamenta della selvicoltura sistemica
La selvicoltura sistemica nasce dalla constatazione che è cambiato il paradigma di riferimento nella conservazione e gestione delle risorse naturali. Forse è proprio questo che ha suscitato tante critiche, perché, come ha scritto Grumbine ([23]), i concetti nuovi sono spesso visti come minacce allo status quo.
Le fondamenta della selvicoltura sistemica, alla luce dell’attuale dibattito in campo scientifico sulla gestione e conservazione degli ecosistemi forestali, appaiono inattaccabili e sicuramente molto più solide di quelle della selvicoltura naturalistica, almeno di quella codificata in letteratura, che fa riferimento a un paradigma scientifico ormai superato.
È indubbio che si è chiuso un ciclo: quello del bosco visto come una entità strumentale che può essere gestita secondo modelli predefiniti per assolvere determinati obiettivi. La storia ha dimostrato chiaramente che oltre due secoli di tentativi di rendere prevedibili i sistemi forestali hanno ridotto i boschi in piantagioni e trasformato la selvicoltura in arboricoltura da legno.
L’attuale dibattito e alcuni esempi di selvicoltura reale nel nostro Paese, dimostrano che chi opera a diretto contatto con il bosco e ha a cuore la sua salvaguardia, spesso è già più avanti del mondo scientifico e accademico, dimostrando così una “saggezza” che la selvicoltura sistemica mira a portare in primo piano, in modo da rendere di nuovo coerenti i presupposti, gli obiettivi e i metodi della selvicoltura e della gestione forestale.
Nessuno vieta a chi lo preferisce di rimanere nel rassicurante paradigma consolidato, ma bisogna essere consapevoli che ritenere questo l’unico sistema di riferimento per tentare di gestire in maniera sostenibile il bosco a fronte della complessità del mondo reale rischia di portare alla definitiva impossibilità di comunicazione e interazione con gli altri attori, scientifici e non, che agiscono nel complesso mondo della gestione e conservazione delle risorse naturali, con la rapida e disastrosa sparizione di qualsiasi spazio professionale per i forestali.
Per fortuna, come ha scritto Popper ([49]), “il mondo è di gran lunga più interessante ed eccitante di come viene immaginato dalla filosofia riduzionista”.
References
CrossRef | Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
CrossRef | Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
CrossRef | Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Online | Google Scholar
CrossRef | Google Scholar
CrossRef | Google Scholar
Google Scholar
CrossRef | Google Scholar
Google Scholar
CrossRef | Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
CrossRef | Google Scholar
CrossRef | Google Scholar
Google Scholar
CrossRef | Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Online | Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Online | Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
CrossRef | Google Scholar
Google Scholar