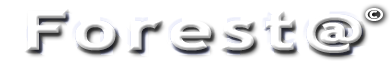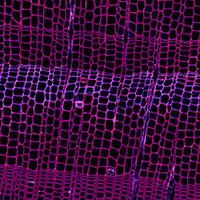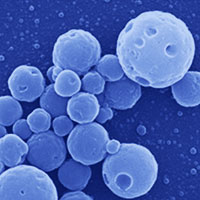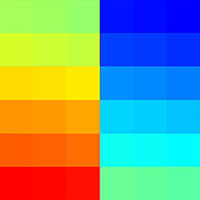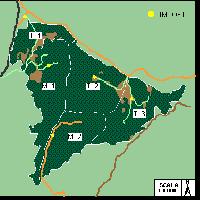Building a wood collection: a brief practical guide to collecting and documenting wood
Forest@ - Journal of Silviculture and Forest Ecology, Volume 22, Pages 66-68 (2025)
doi: https://doi.org/10.3832/efor4897-022
Published: Oct 14, 2025 - Copyright © 2025 SISEF
Commentaries & Perspectives
Abstract
Building a personal or educational xylotheque (a collection of wood samples) is an accessible and rewarding activity that helps document wood diversity, supports identification, and fosters a deeper understanding of trees and their uses. This article offers a practical guide to collecting, preparing, labelling, and storing wood specimens, with hands-on suggestions on finding materials, documenting them, and organising a functional and purposeful collection. It also encourages thematic approaches and provides resources for those interested in creating, expanding, or using their xylotheque for learning, research, or conservation.
Keywords
Wood Anatomy, Botanical Identification, Forest Education, Natural History Collection, Tree Species, Material Conservation
Introduzione
Nel corso delle nostre lezioni sulle caratteristiche e il riconoscimento dei legni, ci capita spesso che uno studente, con una certa curiosità mista a entusiasmo, ci chieda: “Ma se volessi costruirmi una xiloteca tutta mia, da dove comincio?”. È una domanda che ci fa sempre piacere ricevere, perché denota attenzione per la materia e il desiderio di fare proprio e di toccare con mano ciò di cui parliamo in aula: la straordinaria diversità dei legni, delle loro strutture, dei colori, degli odori, delle storie che racchiudono.
Una xiloteca, dal greco xýlon (legno) e theké (custodia), è una raccolta organizzata di legni, ciascuno preparato, etichettato e conservato con attenzione. Può essere un potente strumento didattico, una risorsa per la ricerca scientifica o per l’esposizione in un contesto museale, ma anche una collezione personale che racconta un rapporto diretto con gli alberi e il territorio. Alcune xiloteche sono monumentali, come quelle conservate nei musei o nei dipartimenti universitari o in enti di ricerca, ma molte iniziano in piccolo, con pochi campioni raccolti durante una passeggiata nel bosco, un’escursione botanica o una visita a una falegnameria.
Questo articolo nasce con l’intento di fornire una guida pratica, pensata per chi desidera costruire la propria xiloteca da zero, con mezzi semplici ma con metodo e rigore. Non si tratta solo di raccogliere “pezzi di legno”, ma di documentare, con rispetto e attenzione, una parte della biodiversità vegetale che ci circonda. Descriveremo dove e come cercare i legni, come raccoglierli, prepararli e conservarli, ma anche come attribuire loro un’identità, registrarne la provenienza, e farli parlare attraverso le loro caratteristiche anatomiche. Una bibliografia ragionata, piuttosto che riferimenti inseriti nel testo, fornirà una guida per avvicinarsi al mondo della raccolta dei legni e della loro identificazione.
Dove trovare i legni
La prima grande domanda è: dove si trovano i legni da raccogliere? Verrebbe da rispondere: ovunque ci siano alberi, arbusti o lavori in legno. Ed è in parte vero. Ma non tutti i luoghi sono accessibili liberamente, e non tutti i materiali sono adatti allo scopo. La raccolta di legni per una xiloteca richiede un po’ di spirito d’osservazione, un pizzico di iniziativa e una buona dose di rispetto per l’ambiente e per le regole.
I boschi gestiti sono un ottimo punto di partenza. Se si ha accesso a una foresta pubblica o a una proprietà privata con autorizzazione, si possono raccogliere piccoli rami caduti, porzioni di ceppaie o frammenti lasciati a terra dopo lavori in bosco. È importante non danneggiare alberi vivi né sottrarre materiali in aree protette senza permessi specifici. Anche le potature urbane sono una fonte preziosa, spesso trascurata: molti Comuni, attraverso gli uffici del verde pubblico, effettuano interventi stagionali su alberature stradali e nei parchi. Con un po’ di cortesia, può bastare una telefonata per sapere quando e dove verranno eseguiti, e magari ottenere il permesso di recuperare qualche ramo interessante.
Le falegnamerie, i laboratori di liuteria e le segherie sono un’altra fonte molto utile, specialmente per ottenere campioni di legni esotici o commerciali. Gli scarti di lavorazione, se non sono troppo piccoli o irregolari, possono diventare ottimi campioni da xiloteca. In alcuni casi, si tratta di legni che non crescono in Europa e che dunque permettono di arricchire la xiloteca con materiali esotici spesso dal valore tecnico, storico o culturale significativo.
Infine, non bisogna sottovalutare i mercatini dell’usato, i cantieri di demolizione o le cataste di legna da ardere: con un po’ d’occhio, anche lì si trovano sorprese.
Come raccogliere i campioni
Una volta individuata la fonte, arriva il momento di raccogliere. Scegliere un campione di legno per una xiloteca non è un’operazione banale, e nemmeno una semplice questione di taglio: è un gesto che richiede attenzione, pazienza e una certa cura per i dettagli. Perché un buon campione non è solo “un pezzo di legno”, ma un piccolo documento botanico, tecnico e culturale.
Per iniziare, servono pochi strumenti: un segaccio a mano (quelli da potatura vanno benissimo), un coltello affilato o un cutter robusto, etichette, un pennarello indelebile e qualche sacchetto traspirante (tipo quelli in carta spessa o in tessuto). Avere con sé un taccuino da campo o una app per prendere note è altamente consigliato: ogni campione raccolto va accompagnato da informazioni essenziali che, se non annotate subito, rischiano di andare perse.
Le dimensioni ideali per un campione “da xiloteca” sono di circa 10-15 cm di lunghezza e 2 × 8 cm di lato, ma non esiste una misura fissa. L’importante è che il blocchetto includa una porzione rappresentativa del legno, possibilmente con alburno e durame, e preferibilmente ottenuta da una porzione di fusto o da un ramo abbastanza regolare. Quando possibile, è utile raccogliere anche materiale accessorio: foglie, frutti, corteccia, magari conservati separatamente o fotografati sul posto. Questo aiuterà, in un secondo momento, nell’identificazione della specie e nella documentazione botanica.
Un piccolo trucco che consigliamo sempre agli studenti: numerate ogni campione sul posto con un codice progressivo, scritto direttamente sul legno o sul sacchetto che lo contiene con un pennarello, e annotate quel numero nel taccuino insieme a tutti i dati osservati. Questo semplice accorgimento evita confusione quando queste informazioni verranno catalogate, soprattutto quando si raccolgono più specie in una sola uscita.
Xiloteche tematiche: collezioni con uno scopo
Oltre alla xiloteca “generica”, esiste anche la possibilità di creare xiloteche tematiche, cioè collezioni curate attorno a un’idea o a uno scopo preciso. Un tema comune è quello geografico: raccogliere solo legni di una certa area o ambiente. Questo tipo di collezione è utile per conoscere le specie autoctone e per scopi educativi locali. Un altro approccio è funzionale: costruire una collezione che documenti le specie usate in falegnameria, nella costruzione di strumenti musicali, o nei beni culturali. In questo modo, la xiloteca diventa un ponte tra botanica, artigianato e storia. Ci sono infine xiloteche diagnostiche, pensate per mostrare i segni del degrado: danni causati da insetti, funghi, variazioni cromatiche o difetti e anomalie. Questi campioni sono preziosi per il riconoscimento dei problemi nei manufatti lignei. Creare una xiloteca tematica significa dare direzione e significato alla raccolta. Una collezione con uno scopo è anche uno strumento di comunicazione e coinvolgimento.
Come preparare e conservare i campioni
Dopo la raccolta, viene forse la fase più delicata e trasformativa: quella in cui il pezzo di legno grezzo si trasforma in un vero campione da xiloteca. Preparare bene un campione non richiede macchinari industriali, ma tempo, pazienza e una certa manualità. Un campione ben fatto è leggibile, stabile, maneggiabile, e soprattutto durevole: può conservare indefinitamente, se trattato con le dovute attenzioni.
Il primo passo è l’essiccazione. I campioni raccolti freschi devono asciugarsi lentamente per limitare fessurazioni e deformazioni. L’ideale è sistemarli in un luogo asciutto, ventilato, all’ombra e al riparo dalla luce diretta del sole. Vanno appoggiati su una superficie sollevata da terra e girati ogni tanto nei primi giorni. Evitare assolutamente sacchetti di plastica o contenitori chiusi: il rischio che si sviluppino muffe è altissimo. Per accelerare i tempi si può usare un essiccatore da laboratorio o un piccolo forno elettrico impostato a bassa temperatura, ma è una soluzione che va usata con cautela.
Una volta asciutti, i campioni possono essere squadrati, piallati e levigati. Il formato più diffuso è quello a “mattoncino” con almeno tre facce ben rifinite: una sezione trasversale, una radiale e una tangenziale. Il taglio può essere fatto con una sega da banco o a mano. La piallatura delle superfici longitudinali, eseguita a mano o a macchina, evidenzia l’apparenza naturale del legno, mentre la levigatura con carta abrasiva tende ad “appiattire” la superficie per effetto del riempimento di ogni cavità cellulare con polvere di legno. La superficie trasversale andrà preparata, almeno in parte, con uno strumento a lama affilata; in questo modo risultano meglio visibili i caratteri utili all’identificazione dei legni. Alcuni preferiscono lucidare la superficie con un velo di olio di lino o cera naturale, ma in ambito didattico e scientifico è preferibile lasciare i campioni “al naturale”. È importante proteggerli dalla polvere, dall’umidità e dalla radiazione solare, riponendo in scatole o cassetti ben ventilati.
Infine, per le collezioni più grandi o condivise, può essere utile trattare i campioni contro insetti xilofagi. Un passaggio in microonde per qualche decina di secondi, preferibilmente in un panno inumidito, o in freezer per un paio di settimane è spesso sufficiente per uccidere eventuali larve presenti, soprattutto in legni raccolti all’esterno.
Come etichettare e catalogare i campioni
Etichettare i campioni di legni non significa solo scrivere un nome sulla loro superficie. Significa accompagnare ogni campione con una storia, la sua identità botanica, la sua provenienza, il contesto in cui è stato raccolto.
L’etichettatura più semplice è quella fisica, scritta direttamente sul campione con un pennarello indelebile. Il codice può essere alfanumerico (es. “AC_2025_017”). A questo codice va associata una scheda descrittiva, cartacea oppure digitale.
I dati minimi da raccogliere sono:
- Nome scientifico
- Nome comune
- Famiglia botanica
- Luogo di raccolta
- Data
- Parte della pianta
- Distanza dal luogo di campionamento sulla pianta all’apice
- Note utili
Chi vuole può aggiungere fotografie del campione, della pianta, o del contesto. Le immagini possono essere archiviate in cartelle digitali ordinate per codice. Esistono anche app mobili utili alla catalogazione come iNaturalist o Pl@ntNet.
Per digitalizzare la xiloteca si può usare un foglio Excel™ con colonne per ciascun dato. Una buona organizzazione iniziale permette di evitare confusione o perdite di dati.
Risorse utili per l’identificazione e la documentazione
Chi inizia a costruire una xiloteca personale si trova presto a dover rispondere alla domanda: “Che legno è?”. L’identificazione corretta è un passaggio cruciale, ma affrontabile con metodo. Per affrontare questa sfida, è essenziale dotarsi di strumenti efficaci per l’identificazione del legno. Le tecniche si basano prima di tutto sull’analisi dei caratteri macroscopici osservabili ad occhio nudo o con lenti a basso ingrandimento (10-15×), e poi sull’analisi microscopica a luce trasmessa (40-400×) di sezioni sottili del legno.
Tra le risorse utili per l’identificazione e la documentazione sui legni, la ricca bibliografia che accompagna questo documento elenca atlanti di identificazione macroscopica di legni provenienti da tutto il mondo, alcuni corredati da una chiave di identificazione informatica scaricabile gratuitamente.
Inoltre, è importante utilizzare una nomenclatura corretta e condivisa per evitare ambiguità. Inoltre, alcune università e gli enti di ricerca offrono corsi specifici sull’identificazione del legno, sia a livello macroscopico che microscopico. Partecipare a questi percorsi formativi può rafforzare le competenze necessarie per una corretta gestione e conservazione delle risorse forestali.
Infine, segnaliamo la IWCS - International Wood Collectors Society, una rete internazionale di appassionati, ricercatori e collezionisti che promuove la conoscenza del legno attraverso scambi, pubblicazioni e attività educative. La società pubblica periodicamente il World of Wood, una rivista ricca di schede descrittive, fotografie e articoli specialistici accessibili anche a non addetti ai lavori. Molti degli iscritti poi scambiano e/o vendono campioni, un’ottima opportunità per arricchire la propria collezione con campioni provenienti da tutto il mondo.
Conclusione
Mettere insieme una xiloteca è un’attività relativamente semplice ma carica di significato. Significa raccogliere frammenti di natura e trasformarli in sapere. Bastano curiosità, metodo e rispetto. Anche una piccola collezione può diventare uno strumento didattico, scientifico o personale di grande valore.
Speriamo che queste indicazioni possano servire da punto di partenza per studenti, tecnici, docenti o appassionati.
References
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
CrossRef | Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar
Google Scholar